L’obbligo del silenzio nelle scuole iniziatiche

Il significato del silenzio
Il silenzio è uno degli obblighi comuni per i nuovi adepti della stra grande maggioranza delle scuole iniziatiche che hanno caratterizzato la nostra cultura. Ciò accade e accadde dalle scuole pitagoriche alla massoneria, ma anche in numerosissime altre realtà iniziatiche e non, dove chi è “alle prime armi” è invitato al un silenzio “scolastico” per imparare e per lasciare la parola a maestri più esperti capaci di trasmettere il sapere.
Iniziati, apprendisti o neofiti, da sempre sono chiamati a rimanere in silenzio per due motivi principali: il primo è quello di essere inevitabilmente costretti ad ascoltare le parole di chi invece ha il diritto e l’autorità per parlare, in secondo luogo il neofita ha praticamente come unico compito quello di esercitarsi all’autocontrollo, caratteristica fondamentale per progredire sulla via della conoscenza.
Trattandosi solitamente di un percorso realizzato per gradi, l’accesso alla parola e alle conoscenze superiori, viene concesso nel momento in cui l’iniziato si dimostra capace di autocontrollo o degno del nuovo e superiore livello di conoscenza.
Ma in fin dei conti cos’è il silenzio? Per sua definizione può essere considerato come assenza di rumore o di suono, ma le risposte sono tante e diverse, ed esso può essere vissuto o definito anche come introspezione, concentrazione , ascolto , assenza, presenza, sentimento, apprendimento oppure attenzione.
Il silenzio per l’uomo ha sempre avuto un valore importantissimo , riferito al contatto con la natura e con se stesso, con le profondità del proprio animo.
Nelle antiche scuole iniziatiche, quali ad esempio la scuola pitagorica, veniva imposto ai novizi un periodo di silenzio lungo 7 anni; durante questo periodo essi avevano il solo dovere di tacere e lavorare per il bene comune, per il bene del gruppo, astenendosi da qualsiasi attività potesse distoglierli dalla ascolto degli insegnamenti dei maestri o dalla meditazione.
Sulla base di questi primi concetti già da ora è possibile, a buona ragione, affermare che il silenzio sia uno strumento, utile a svolgere un lavoro di conoscenza interiore ed apprendimento.
E quindi, tornando alla domanda posta al principio della tavola, che cosa è il silenzio? E inoltre, come utilizzarlo? Cosa ascoltare? Cosa sentire?
Conoscendo ed incontrando moltissime persone, potendo parlare con loro ed ascoltandone i diversi punti di vista, ci siamo sempre più convinti che il silenzio fosse principalmente connesso con i concetti di spazio e tempo e che tramite esso si potesse intraprendere un lavoro attivo.
L’individuo che rispetta la consegna del silenzio si trova nella condizione di poter creare spazio nel proprio animo, di poter darsi tempo, di poter limitare le pulsioni legate al proprio ego e, quindi, a principiare la comprensione del concetto di scavare nella profondità di sé stesso.
Il silenzio predispone all’ascolto ed in questo modo crea i presupposti per accogliere le idee altrui. La forzata astensione dall’atto di prendere parola impone all’ascoltatore di superare la barriera creata dai propri pregiudizi, di porsi con apertura e buona predisposizione d’animo di fronte alle idee ed ai concetti che si trova ad ascoltare.
Il neofita in questo modo, non potendo far prevalere il proprio ego in una dinamica pubblica di azione / reazione, si trova nella condizione di dover ascoltare e valutare le diverse argomentazioni valutando quanto potranno essere vicine alla propria sensibilità, al proprio animo per sentire, per cultura e per convinzione.
Con il silenzio l’iniziato dilata la percezione del proprio animo, riesce ad avvertire sensazioni più chiare ed in maniera più diretta, in tal modo svolge un lavoro attivo in cui raffina la propria sensibilità.
Lo spazio creato si riempie, diventa pesante, quasi materiale, finché come avviene per l’acqua filtrata da un panno, passando da un livello superficiale a uno più profondo, raggiunge le corde dell’animo e lì avviene l’inaspettato: un vivido momento di luminosità, un bagliore in cui il la conoscenza compare, si palesa concretamente, prorompendo con prepotenza sui piani emotivo e razionale, imponendo le più diverse riflessioni sui vari aspetti della vita; come ben ha detto Yves Congar “Il modo più vero per sentire è ascoltare“.
Il silenzio implica l’accettazione di un lavoro che richiede il compimento in tempi naturali che non possono essere forzati dall’ego.
I concetti veicolati all’ascoltatore spesso entrano nell’animo e nella comprensione con tempi differiti, non immediati; i tempi sono da considerarsi differiti a seconda della sensibilità e della preparazione dell’ascoltatore.
Il silenzio, quando non è una scelta spontanea dell’individuo, implica fatica.
Esso è una forzatura ed una limitazione dell’ego, quasi una violenza che però deve essere considerata necessaria, anche nell’apprendimento di una buona educazione.
Il rispetto del silenzio è utile per acquisire una delle prime e fondamentali lezioni: l’apprendimento della tolleranza, la rinuncia a comportamenti tesi alla prevalenza delle proprie ragioni, la consapevolezza che la propria idea è parte integrante di un più ampio e completo flusso di valutazioni e concetti e come tale deve in esse essere integrata e non contrapposta, come in una sinfonia dove tutte le note sono collocate armonicamente.
Col silenzio si tenta di creare la virtù della tolleranza, della comprensione, dell’accoglimento verso il diverso, verso il lontano da noi.
Riassumendo, il vero scopo del silenzio è quello di sviluppare una sensibilità, far arrivare a livello profondo la parola altrui e lasciare che essa lavori nella psiche sprigionando tutto il proprio potere pervasivo e suggestivo. Questo accade anche nella vita di tutti i giorni quando, ascoltando in silenzio, riusciamo ad entrare in empatia con chi ci sta di fronte ed a comprenderlo veramente grazie alle emozioni che le sue parole smuovono e fanno vibrare dentro di noi.
L’individuo che sceglie un atteggiamento di questo tipo, si pone in contatto con la profondità del suo animo e con la grandezza dell’universo, realizzando, così, nella connessione di entrambi, un moto legato al V.I.T.R.I.O.L. ed al concetto del “Così è nel piccolo come nel grande“, o in maniera diversa, “così è dentro come è fuori”.
E’ in tale modo che l’individuo viene a conoscenza del significato di verità a lui prima celate e precluse: egli progressivamente abbandona la sua primigenia natura rozza (processo già incominciato con rito di iniziazione), per rendersi più forte nel percorso che ha scelto di affrontare.
Il silenzio diviene, così, un’opportunità di conoscenza e ascolto verso sé stessi; in tal modo si da impulso ad un percorso virtuoso ove la conoscenza porta alla consapevolezza, la quale, a sua volta conduce alla saggezza, la quale, infine porta alla realizzazione di sé stessi, a trovare la propria forza.
Come poc’anzi detto il silenzio è connesso non solo all’ascolto ma anche al proprio sentire, pertanto anche alla conoscenza di sé e dell’altro; più vi è silenzio più vengono percepite le reazioni corporee connesse all’agire dell’altra persona o in relazione a diverse situazioni. Riuscendo a stare in silenzio, a creare spazio dentro se stesso, l’uomo può percepire alterazioni corporee; non è forse vero che in periodi di felicità o di innamoramento si dice di avere le “farfalle nello stomaco”, così come quando si è preoccupati per qualcosa si dice di avere lo “stomaco chiuso”? Che alcune parole creano pesi o pesantezza sulle spalle? O altri i sudori freddi?
Di regola il silenzio, inteso come ascoltare o sentire connette gli uomini in un legame empatico che crea fiducia e vicinanza; in questo senso quindi può essere interpretato come la realizzazione di un abbraccio in cui le persone si stringono, riconoscenti per aver creato emozioni che si porteranno nel ricordo dei giorni a venire e che essi hanno, durante il loro incontro, stabilito un legame che si rivelerà confidente, intimo, utile gli uni per gli altri.
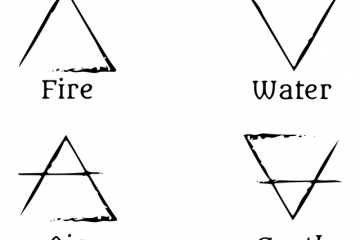



0 commenti